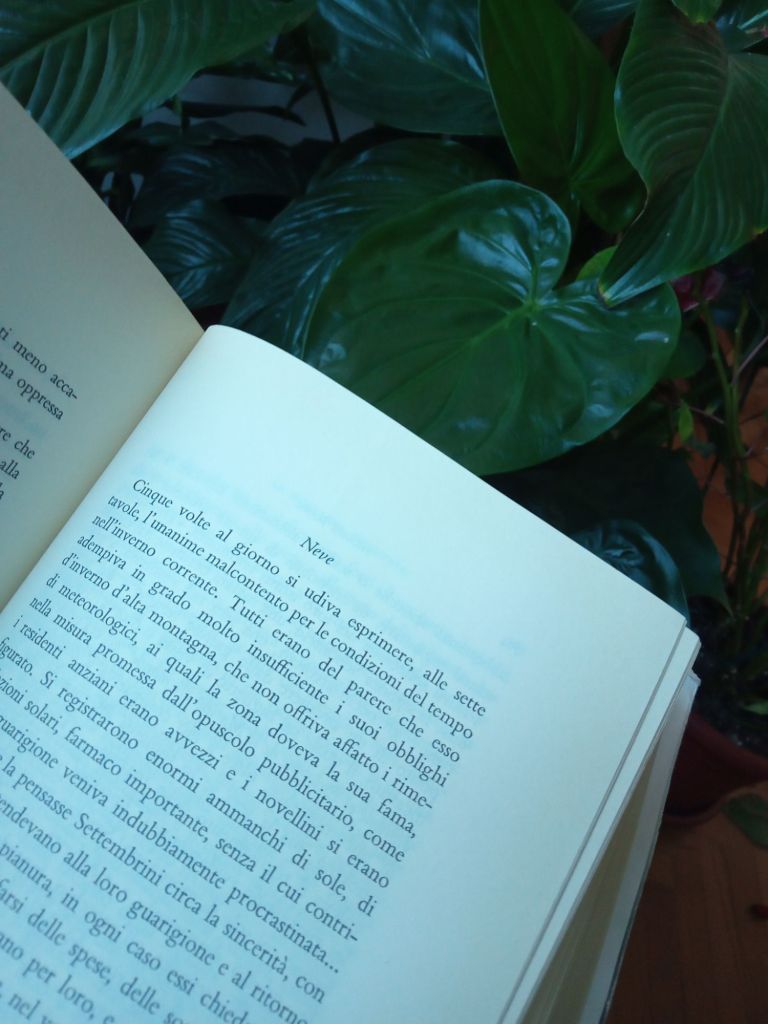TYPUS MELANCHOLICUS LOQUITUR
Sul fatto che io sia angosciato non v’è da discutere: riconosco certa inclinazione naturale, quasi un istinto spietato, al farmi nodo inestricabile di timori e di tremori. Né mi appartiene il gesto aperto, né mi appartiene la visione limpida; sicché ogni cosa che guardo, in effetto, si increspa, si arrotola, si chiude su sé come un enigma ostile.
E così, quasi inevitabilmente, penso al porcospino – a un porcospino immaginario, guardiano incognito dei confini che non si varcano, custode di un regno fatto di silenzi, di passi minuscoli, di…
Lo immagino all’ora tarda, quando il mondo si sfila dal giorno e la terra respira appena. Il porcospino emerge allora dal suo recesso, il muso indagatore, le zampe incerte, le spine che luccicano al chiarore della luna – se solo la luna si concede. Si ferma, ascolta, e la sua intera presenza si concentra in un muto rifiuto. Custode del suo isolamento e coacervo di dinieghi.
Vi sono però istanti – rari, rari come il brillio di una cometa – in cui mi smarrisco. Non è un abbandono, né un trionfo; è piuttosto un cedimento sottile, una crepa nell’angoscia che lascia filtrare l’ebbrezza. Mi accade di rado, e ogni volta con la medesima, inevitabile, dolce violenza: il corpo si distende, il respiro si fa ampio – e io dimentico le spine. È un momento senza geometria, senza peso.
So che è illusione – e so che mi è cara. Perché quando l’ebbrezza si ritira, quando il corpo si ridesta, trovo lui ad attendermi. Lui, il porcospino, non è mai andato via – è lì, immobile, intatto, perfetto nella sua solitudine ferita. Ci guardiamo allora, lui e io, con l’intesa di chi si conosce da sempre. E mentre il giorno torna a inchiodarmi al suolo, so che non lo tradirò mai.
IL RAFFREDDORE DI DEMETRIO
Tragicommedia in un atto
Dramatis Personae
Demetrio: Un pupazzo dallo spirito tragico, tormentato dall’illusione di un raffreddore.
Oria: Gallina di pezza zoppa, sarcastica e disincantata.
Atto Unico
Scena unica
Una vecchia torre praticamente diruta. Demetrio giace sprofondato in una poltrona senza braccioli, con l’aria di chi porta sulle spalle il peso di questo mondo. Oria è accanto a un tavolo, intenta a spostare tazze e piattini con movimenti ripetitivi.
DEMETRIO (inclinando la testa con aria grave, tossendo appena)
Dicono che un pupazzo non possa buscarsi il raffreddore, che la stoffa non conosca il… il languore di un naso che gocciola o la pena d’un respiro affannato. Ma io, Demetrio, smentisco coteste illazioni con la viva testimonianza del mio tormento. Ogni starnuto è una battaglia perduta nel grande assedio dell’esistenza.
ORIA (senza voltarsi, con un tono annoiato)
Se questa è una battaglia… forse hai solo dimenticato di rammendarti per tempo. O, più probabilmente, hai trovato una scusa per restare imbambolato sulla poltrona.
DEMETRIO (alzando lo sguardo al cielo, declamando)
Una scusa? Che concetto artigianale! Non una scusa è questa, bensì un’epopea! Qui, sotto il cappello a coccarda, una testa mi scoppia; qui, in mezzo alla faccia, un naso mi gocciola.
ORIA (sbattendo la zampa zoppa con stizza)
Sei un pupazzo, e i pupazzi non hanno male alle teste né nasi che gocciolino.
DEMETRIO (con un gesto drammatico, alzandosi a fatica)
Non senti tu le ali del tempo sfiorare questa torre con un brivido? Perché hai serrato il battente? Perché non lasci che io possa scorgere un raggio di luce oltre la mia clausura?
ORIA (sospirando, posando una tazza sul tavolo)
Zuccone! Nemmeno ci è concesso muoverci senza una mano che ci inciti, figuriamoci morire!
DEMETRIO (crollando sulla poltrona, con una voce mesta e profonda)
E allora dimmi, Oria: cos’è questa pena che strazia le mie fibre? Non è forse l’ombra di un male senza rimedio? La polvere si accumula, la tela si scuce, e restiamo qui, condannati a parodiare un senso ormai perduto.
ORIA (alzando lo sguardo al soffitto, sarcastica)
Non c’è un senso, Demetrio. Né oggi, né mai. Recita la tua battuta, chiudi la scena e lasciami in pace.
DEMETRIO (pensando per un istante, poi sorridendo amaramente)
Eccola: siamo pupazzi. Non abbiamo futuro. Ma almeno non abbiamo nemmeno il raffreddore.
(Pausa, con tono grave)
Oria, hai ragione. Non c’è rimedio al nostro male: siamo condannati a recitare ciò che non possiamo vivere.
Sipario.
LE MAPPE IMPOSSIBILI DI SOLIPSIA
A Solipsia, ogni mappa è un reticolo di allucinazioni (espressioni) che solo il suo autore è in grado di interpretare. Non di errore o fraintendimento si tratta, bensì di una legge ineluttabile che governa la cartografia solipsiana: il mondo non esiste; il mondo è solo un riflesso del mio sguardo (speculum animi). Nella loro lingua il termine ‘territorio’ coincide con ‘io’ e, in una sfumatura secondaria, con ‘reale’ (τὸ ὄντα). Il lettore perciò inferisca da sé.
Le mappe, dunque. Ho avuto modo di studiarne alcune durante una breve visita al Museo cartografico solipsiano. Ho visto mappe che non indicano strade ma stati d’animo, fiumi che si interrompono per diventare frasi di un diario, montagne disegnate con tratti che ricordano il battito di un cuore. Sono, queste mappe, piene di dettagli insignificanti quanto mirabili (mirabilia minora). Una riproduceva il giardino del suo artefice ridotto a un puntolino, una scritta a margine diceva: «Lì ho capito che la felicità non è che l’ombra di un albero». Un’altra, intitolata «Gli oggetti che ho smarrito», presentava unicamente macchie d’inchiostro.
I cartografi di Solipsia sono straordinariamente eloquenti nel giustificare questa loro peculiarità. Prima di mostrarvi una delle loro creazioni, vi terranno un lungo discorso sul valore dell’unicità, sulla inattendibilità delle mappe comuni e sull’importanza di «perdersi nella propria idiosincrasia» (hic sunt dracones). Ogni piega della pergamena trasuda di un orgoglio che rasenta l’arroganza. Anche per questo i cartografi di Solipsia non collaborano mai. Una mappa condivisa è una mappa tradita.
Ovviamente, non mancano i detrattori. Gli esperti di cartografia classica accusano i solipsiani di egocentrismo, di una deliberata oscurità tecnica. Ma i solipsiani non si curano delle critiche. A questo proposito, il famoso geografo Marlapin è considerato una voce distorta. Egli si smarrì un giorno seguendo una mappa solipsiana, e il rancore per quella disavventura emerge in ogni pagina dei suoi saggi.
Alla fine della mia visita, ho ricevuto in dono una mappa intitolata «Le vie inevase». Non vi compariva alcun segno. «Tracciale tu stesso» mi hanno detto. Sono rimasto a fissarla con animo peritoso. Forse, a loro modo, sono nel giusto.
Nota: si potrebbe dire che, a Solipsia, non c’è nessuno disposto a contraddire il filosofo Berkeley, che Sergio Quinzio separava rigorosamente dal vescovo Berkeley. Ecco un passaggio del primo, giustappunto (e cioè del filosofo): «It is indeed an opinion strangely prevailing amongst men, that houses, mountains, rivers, and in a word all sensible objects have an existence natural or real, distinct from their being perceived by the understanding» (Of the Principles of Human Knowledge, Part I, §4).
𝐈𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐯𝐞𝐠𝐥𝐢𝐞: 𝐮𝐧 𝐠𝐮𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨
𝑈𝑛 𝑔𝑢𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑓𝑎 𝑟𝑖𝑓𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑓𝑖 𝑠𝑢𝑙 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
Chartres, 8 gennaio 2025. Venticinque filosofi hanno perso l’appuntamento mattutino a causa di un guasto simultaneo delle loro sveglie, tutte impostate sulle sette. L’inconveniente ha offerto lo spunto per una riflessione profonda. Nel pomeriggio, il convegno è iniziato con una provocazione: «Esistiamo davvero se nessuno ci sveglia?» L’osservazione, in linea con la tradizione filosofica, è stata subito riformulata in un dubito ergo dormio.
Dunque, signore e signori, non inadeguatamente potremo definire Cosimo Vecchione non solo l’incarnazione del luogo comune, ma la sua proliferazione entropica, vulgo inarrestabile. Nei suoi discorsi, esso, il luogo comune, non è più mezzo, bensì fine, fine in sé: un’eco che si perpetua fino a svuotarsi, una reiterazione che esaurisce il senso per volgerlo in simulacro. Vecchione non trasforma, Vecchione non crea: accumula. Vecchione non ricerca un’origine – che, va da sé, è sempre preclusa, inattingibile perché, signore e signori, lo sanno pure i sassi, non esistono cose extra interpretationem – né un significato condiviso. Il suo parlare è un’abitudine che si autonutre, una parodia inconsapevole.
Prendiamo, per esempio, una delle sue massime preferite: «Meglio un uovo oggi che una gallina domani». Vecchione, con il suo caratteristico slancio, sembra voler aggiungere un tocco personale: «Chi è questa gallina? L’eterno femminino? Una promessa mancata?». Non siamo di fronte a un proverbio che si apre a nuove possibilità di senso, men che meno al simbolo dei o di alcuni romantici che già… insomma a quei casi disperati… eminenti, di cui Goethe scrive a Schiller, che rappresentano molti altri in una caratteristica molteplicità, racchiudendo in sé una particolare totalità ecc… bensì … bensì a un gioco che esaspera la forma e riflette solo il vuoto. È il luogo comune che si compiace di sé. Nel senso indicato da Antoine Compagnon? Permettetemi di dubitarne.
Ecco allora, signore e signori, le manifestazioni della sua, di Vecchione, logica: una grossolana impazienza pomeridiana, un singhiozzo tra il digestivo e il morale, un gesto d’ira per una battuta travisata, un amore subitaneo e irragionevole per una vecchia poltrona. Non confondiamoli, questi, con drammi individuali. Ogni sua azione, di Vecchione, è un rituale codificato, un piccolo gesto scenico, un abito, un abito di risposta che non realizza un senso, ma ne simula l’esistenza senza malizia.
Cosimo Vecchione, dunque, non è soltanto un uomo. Cosimo Vecchione è uno specchio deformante, è un errore, è… idiosincrasia. Ed ecco perché, signore e signori, Vecchione non è esattamente il nostro pane quotidiano. E, parlando di pane, ora termino. Vado a comprarlo.
L’uomo resta sulla soglia, immobile come un manichino. Sulle scale, un manipolo di individui goffi si arrabatta: trascinano giù una lavatrice che oppone resistenza, che stride e protesta. La porta d’ingresso, colpita e umiliata, si incrina con un lamento secco, un crepitio di osso spezzato. Intorno, un lemure, curvo e spelacchiato, avanza come un’ombra servile. Sussurra frasi smozzicate, disperse nei clangori. Salire al piano di sopra, per l’uomo, è un atto inconsapevole: una caduta al contrario. L’appartamento lo accoglie con il suo disordine minerale: vetri sparsi, macchie scure. Nel bagno, una luce itterica, filtrata, che sa di polvere. Lo specchio, attraversato da incrinature, restituisce un volto frantumato, un mosaico di frammenti estranei. L’uomo porta una mano al petto. Il cuore, traditore, si inceppa: un battito fuori tempo lo lascia in apnea. L’uomo torna nel suo appartamento, si lascia cadere su una sedia. Pensa che dovrebbe fare qualcosa, qualunque cosa. Ma poi, con quieta disperazione, decide che no, non ne vale la pena.
Promemoria. Che Publio martedì inaugura la dentiera nuova e invita gli amici a un tè muto. Che la faccia tosta si smonta con un cacciavite, dentiera compresa. E se qualcuno osasse chiedere, con malcelata perplessità: «Ma davvero senza dentiera?», la risposta sarebbe: «Mi perdoni, ma forse senza certi vincoli gli ingranaggi della lubrificazione girano più fluidi, più sfacciati». Poi Decimo gli regala un sorriso sgombro, mentre il silenzio si accartoccia.